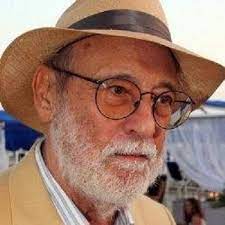Un ponte tra realtà e immaginazione
Vi sono sempre state tante maniere di intendere e fare arte. Ciò che per secoli ha dominato è l’arte intesa come documentazione del reale. Si è fatta arte, scultura e pittura, che riproducevano ciò che l’artista vedeva immettendo nell’opera. Poi si inventò la fotografia e il reale ebbe la sua forma più precisata cosicché i pittori cominciarono a prendere altre strade, sorsero l’astrattismo e l’informale.
Queste problematiche legate all’espressione interessarono e interessano non solo e soltanto pittori, grafici, scultori, registi di cinema e televisione. Ma occuparono anche filosofi e politici. In Russia sovietica e poi anche in Germania nazista i capi imposero un’arte che il popolo doveva capire definendo degenerata tutta l’arte che rifuggiva l’orgoglio della figura così com’è o così come si voleva che fosse.
Seguivano i dettami di quelle committenze artistiche, che erano stati i Papi e i Re, potesse nei secoli a farsi ritrarre (come Napoleone) più belli del bello, nel vero più intonato alla propaganda. Che c’entra tutto questo con Giovanni “Menghino” Lazzarini? C’entra perché lui, artista poliedrico e assai interessato ai problemi dell’arte, in una Viareggio che uscita dall’ultima guerra aveva come unica lezione l’esempio di Lorenzo Viani, essendo al tempo stesso pittore e politico impegnato nella trasformazione della società, viveva per le sue creazioni il dilemma: fare realismo perché produttivo di idealità rivoluzionare o dare sfogo all’immaginazione e agli scatti della fantasia sollecitata dallo Spirito? Lazzarini produceva in due direzioni: i carri del Carnevale e i quadri (e le sculture).
Il Carnevale , regno delle maschere, di per sé stimolava e stimola alle bizzarrie sacralizzando per questa stagione (appunto il mese che precede la Quaresima) i sentimenti più laici possibili, il sesso, la satira, la goduria gastronomica, le perversioni. Che carnevale poteva e può fare un realista? In altra strada, quella dell’arte figurativa, Lazzarini doveva rifuggire le illusioni, fare narrativa come insegnava Renato Guttuso, oppure seguire il noto slogan sessantottino “l’immaginazione al potere?” La recente mostra a palazzo Paolina, direi antologica perché comprensiva di tanto e tutto ciò che Lazzarini aveva prodotto, ha ampiamente risposto a queste domande. Cosicché si può precisare l’intero percorso artistico di “Menghino”.
Nel carnevale egli scelse di indicare un insegnamento “politico” attingendo, nei mascheroni , non ad un facile populismo ma ampie divagazioni moderniste un po’ riprese dall’espressionismo tedesco un po’ dai materiali della pubblicità. Ciò lo rese efficacissimo sia perché usò forme coraggiose e spettacolari sia perché usò colori avvincenti.
Più che populista fu “Pop” e per questo piacque assai ai giovani rocchettari. Nei quadri (e nelle sculture) egli ideò un “proprio popolo” (così come faceva Viani) dimostrando la sua passione al proletariato che pur non esistendo più, vedi il trionfo della mondializzazione merita , però rammentare come origine della “ viaregginità” e merita anche segnalare per l’ accesa vocazione alla “comunità (ahimè perduta)!
Ma a fianco di questa scelta anche estetica, vi è poi un Lazzarini visionario, ricco di suggestioni, che si manifesta nei totem, nelle vetrate, nelle ceramiche, nei murales, nei collages, nelle maschere, nelle sculture in legno, nei cosiddetti “mondi fantastici”. E qui prorompe, esuberante, un’immaginario che è al tempo medesimo ironico e simbolico, riprende figurazioni della fumettistica alla moda con tante irruzioni di eroi superlativi e violentissimi scatti di colore.
All’interno del capannone dove si costruiranno i carri fa così irruzione nella mente dell’artista un diluvio di provocazioni, una miscela esplosiva di oggetti che non hanno niente a che vedere con l’impegno politico o educativo ma che si aggirano nella società, mica nei cunicoli sotterranei, bensì nella comunicazione di massa, che alterano nel delirio la razionalità illuminista e la fisicità naturale.
Giovanni Lazzarini ha così saputo cogliere e il sogno della memoria (i suoi pescatori, i suoi vageri) e l’apocalisse del pensiero organico, gli angeli e i cristi dei nostri incanti ideali e i demoni e i deliri dei videogames. Non è poco. Nelle sue opere Giovanni “Menghino” Lazzarini seppe fare (e fa), da ponte tra valori tradizionali e ossessioni del sapere-potere. Ed ecco il suo talento, seppe rendere comprensibili le “sue” soluzioni.
Adolfo Lippi
Da “Il Tirreno”
–
03/2018
Menghino: l’artista, l’uomo e l’intellettuale
Palazzo Paolina ospita una mostra di Giovanni Lazzarini “Menghino”, costruttore di carri, pittore e scultore, intellettuale di sinistra negli anni pre e post 68 . Aderì a “Il Manifesto”, fu espulso dal PCI, La mostra ordinata da Alessandra Belluomini Pucci (che dirige la GAMC di piazza Mazzini) si presenta a diverse letture: è arte di un pittore che fu carrista? È formula nazional- popolare? È opera di ricerca di anni di trasformazioni profonde della coscienza collettiva?
Giovanni Lazzarini può piacere o non piacere. Ha rappresentato tuttavia un’esperienza di indiscutibile interesse artistico e politico. …Giovanni Lazzarini aveva nel sangue un’arte che non disdegnava la realtà circostante era attento lettore, era assertore di idee, polemico e intrigante, era fin da giovane personaggio pubblico perché iscritto al PCI e perché partecipante acceso di assemblee e riunioni.
Fece il carrista, cioè si mise a costruire carri per il Carnevale… ….Lazzarini , alle prime prove con la pittura, si mise sulla scia di Viani, Santini, cioè dipinse darsene e figure naturalistiche. Epperò capì che su questa strada sarebbe andato poco lontano. Già troppo arata e frequentata. Così prese la palla al balzo la corrente di “nuova figurazione” (che stava nascendo a Milano grazie ad alcuni critici di sinistra) e come altri viareggini (Martinelli, Luporini, Mannocci, Giannini) si mise a fare quadri che rappresentavano l’alienazione provocata dal consumo di spazi, oggetti, architetture.
Era una pittura piuttosto difficile. E poi era difficile da capire, soprattutto da parte delle masse popolari alle quali Lazzarini teneva moltissimo. …In pittura Lazzarini abbandonò quindi l’elitaria “nuova figurazione” e grazie alla sua nuova amicizia con Cesare Zavattini (con l’ancoraggio poetico a Tonino Guerra, sceneggiatore di Federico Fellini in “Amarcord”), trovò una formula tra il naif e il nazional-popolare.
Venne ospitata nei quadri una comunità gagliarda e popolaresca, ideologica, impostata nel ricordo (le masse non erano così da anni), che a livello nazionale fu anche affermata dal pittore siciliano Migneco. La mostra a Palazzo Paolina contiene soprattutto lavori di quest’ultimo finale di “Menghino”. Ma egli non sarebbe giunto a queste formule se non avesse traversato le altre dimensioni: la politica, la vita, la cultura progressista, la costruzione dei carri del Carnevale.
Adolfo Lippi 03/2018
Sognare per trasformare
Con Giovanni “Menghino” Lazzarini compiamo un viaggio iniziativo a Roma negli anni 60. Per mesi, sul lungomare, sui moli, agli hangars del carnevale avevamo parlato, più che altro avevo ascoltato, le lunghe, appassionate interpretazioni della realtà che si poneva di fronte a noi, modesti ma arditi e ambiziosissimi “speculatori” viareggini, speculatori nel senso di filosofi e sociologi di Provincia. Giovanni era un intellettuale puro, veniva da una casata aperta al mondo, padre marinaio, nonno trattore, e nulla gli piaceva di ciò che ci circondava, intendo la società immobile e congelata (di qua i democristiani di là i comunisti), che sfiorava il boom ma manteneva intatte le ingiustizie sociali e le divisioni classiste.
Così parlavamo e parlavamo su come sarebbe stato possibile cambiare le cose. E lui si impegnava tanto nel partito comunista e nel carnevale dove, assieme a Silvano Avanzini e Arnaldo Galli, si provava ad inserire elementi di satira politica. Che io, sul giornale, descrivevo con simpatia. Erano anni di trasformazioni, non erano ancora giunti gli echi della contestazione studentesca (che nacque di lì a poco negli Stati Uniti e in Francia), ma le coscienze ribollivano, poiché leggevamo di tutto, da Marcuse ad Umberto Eco, dalle “ceneri di Gramsci” alle poesie del mitico Mao Tse Tung.
Giovanni cercava, come tutti, una sua via. Ma la cercava soprattutto in pittura poiché non gli bastava la lezione dei maestri locali quali Mario Marcucci o Renato Santini che dipingevano su moduli poetici, intimisti, esistenziali e, a differenza di quel mito quale Lorenzo Viani, non coglievano le miserie dei ceti sociali emarginati e crocifissi, i “vageri” appunto. Giovanni, decidendo con me, di sondare Roma e le gallerie d’arte che erano assai vicine al PCI e a Renato Guttuso, voleva capire quale arte si potesse fare per fedeltà al popolo e al mondo del lavoro che lui sentiva così vicini alla sua coscienza.
Ma la sua fantasia? Ecco, questo era il problema. L’arte figurativa non è fotografia, non è solo documentazione. Restando a Roma e frequentando ambienti che erano già stati visitati da pittori viareggini quali Fausto Maria Liberatore, Eugenio Pieraccini, Mario Francesconi, fu fatta la scoperta di una lezione, quella di Cesare Zavattini, che non si era mai lasciato ingabbiare, lui pur così militante nella sinistra politica, dai dettami dello zdanovismo stalinista e togliattiano. Che imponevano “un’arte che deve capire e istruire il popolo”.
Zavattini, autore de “il miracolo a Milano” aveva sempre lasciato intendere che, invece, l’arte è anche sogno, è anche oltre la realtà. Così Giovanni Lazzarini andò poi a conoscere, a Luzzara, Zavattini, e secondo me lì inizia la sua vera vocazione alla pittura. Nascono così i quadri e i murales dove il popolo viene trasformato. Non è un popolo esistente. E’ un popolo comunità che utopia dell’immaginario diviene, con l’arte di Lazzarini, un vero esistente, con le sue bandiere, i suoi riti, il suo stare magico nei lavori più semplici, quelli dei pescatori, quelli dei calafati. Dopo il viaggio a Roma, Lazzarini non solo si infiammò d’arte ma prese a costruire carri meravigliosi, segni di una creatività espansiva.
Non fu una meteora. La sua lezione, che è quella di istruirsi, comprendere, acculturarsi, capire, trasformarsi, rimane per i creativi di oggi.